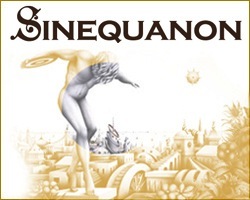In Myanmar. Una massa di granito che pesa seicento tonnellate, ricoperta da uno spesso strato d’oro, in mirabolante bilico su uno strapiombo alla sommità di una montagna: Kyaikhtiyo.
La Pagoda di Kyaikhtiyo è uno dei luoghi più sacri del Myanmar, ed è sorretta da un singolo capello. Che, beninteso, non è un capello qualsiasi. Ma, come vuole la leggenda, un capello di Buddha che miracolosamente impedisce al ciclopico macigno di precipitare giù nella vallata sottostante.

Questo venerato capello viene gelosamente custodito in una teca dentro un piccolo stupa sulla sommità della Roccia d’Oro
– Kyaikhtiyo, che si pronuncia ciai-ti-o – e nel dialetto Mon significa “la pagoda portata sulla testa dell’eremita”. Infatti, è stato un eremita che nell’XI secolo ha portato fin qui il capello nascosto nel ciuffo di capelli raccolti sulla propria testa, lasciando scritto prima di morire di cercare un masso che avesse la forma della sua testa per conservare il prezioso capello del Buddha.
Il santuario dista un paio di ore in macchina da Yangon, ma il vero viaggio inizia arrivati al campo base di Kinpun, ai piedi del Monte Khaikhtiyo, da dove si parte per la seconda tappa verso la Roccia d’Oro. Seduti fianco a fianco, sei per fila, su panche di legno all’aperto su un pesante camion che trasporta una cinquantina di persone, per undici chilometri si sale una strada tortuosa, attraversando la foresta tropicale fino ad arrivare alla grande piazza di Yatetaung dove parcheggiano i mezzi di trasporto.

Da qui sono in molti a fare l’ultima tappa a piedi, impegnando oltre un’ora per salire il viottolo serpeggiante e le ripide scale di legno. Altri, soprattutto i turisti, si fanno trasportare su lettighe issate sulle spalle di muscolosi giovani. Semi-sdraiati su un sacco da riso dismesso legato a due robuste aste di bambù, dopo una quarantina di minuti di sballottamenti, dovuti al passo ritmico e sostenuto dei quattro portatori che si fermano spesso lungo la ripida salita per prendere fiato, si arriva finalmente alla sommità.
Straordinaria l’illusione di poter toccare il cielo con un dito. E di prima mattina, quando le nuvole avviluppano i viandanti in un leggiadro manto luminoso, si ha la sensazione di essersi perduti in un’altra dimensione. Silenziosa, suggestiva, solenne. Ogni anno a novembre, il grande piazzale antistante Kyaikhtiyo, la Roccia d’Oro del Myanmar, viene illuminato da 9.000 lumi, mentre 9.000 fiori profumati vengono sparpagliati intorno per celebrare la reliquia.

Ma in tutte le stagioni migliaia di pellegrini arrivano qui con negli occhi la luce della speranza e sul viso quel sorriso dolce e radioso che è una caratteristica del popolo birmano. Solo agli uomini è consentito toccare il santuario, e quindi sono loro che con grande dedizione e pazienza, aggiungono di continuo piccoli quadratini di fogli d’oro sulla Roccia.
Creando lentamente un nuovo strato in modo che il macigno non perda, neanche per un instante, la sua incandescente doratura che, mentre “il grande orbo” tramonta dietro le montagne, assume sfumature dal rosa al purpureo. Intorno al grande piazzale della Pagoda di Kyaikhtiyo sono tante le bancarelle che vendono offerte, lumi e ornamenti sacri e, dopo il tramonto, il momento più solenne davanti al santuario, quando nell’aria s’innalzano i profumi dei bracieri dove vengono cotti pesce, carne e verdure.

Molti pellegrini, stanchi ma rinvigoriti dalla presenza di tanta bellezza e sacralità, rimangono svegli tutta la notte. Seduti a tavolini bassi o in piccoli gruppi lungo il perimetro del monte per consumare l’ultimo pasto, sorseggiare tazze di tè, raccontare il loro pellegrinaggio e pregare. Per molti l’esperienza di una vita. Per altri, un felice ritorno. Per altri ancora, la prima volta di un pellegrinaggio da perpetuare.
Intorno, tutto tace. I declivi densamente tappezzati di vegetazione lussureggiante si confondono dietro i chiaroscuri della luna, e sul Monte Kyaikhtiyo si sente solo il mormorio delle preghiere, il fruscio di passi rispettosi, e quell’inconfondibile suono del silenzio, privilegio dei luoghi di profonda e secolare sacralità.
Testo di Pamela McCourt Francescone