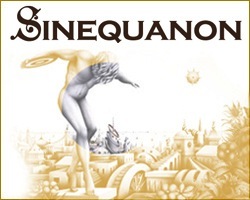ALLA RICERCA DEI LIMITI DELLA SCIENZA
riflessioni sulle implicazioni morali della ricerca biomedica
Di Teresa Carrubba
Una carriera, quella di Sergio Zavoli, percorsa quasi interamente alla Rai. In tutti questi anni non si è impegnato solo a dirigere e coordinare, e non si è disperso nel marasma di parole e fatti, ma ha continuamente approfondito la sua vasta analisi di scrittore sulle prospettive e gli handicap contemporanei. E’ la psicologia il più rilevante interesse di Zavoli, e il sistema a lui più confacente è la ricerca della verità dell’uomo attraverso la storia, l’attenzione ai grandi temi, quelli a cui è legata la sopravvivenza stessa dell’individuo. L’esperienza del giornalista, la tecnica del narratore, le riflessioni del saggista, gli sono valse una laurea in lettere Honoris Causa e 25 libri nei quali Zavoli penetra la dura scorza della realtà e il sottile velo della memoria: richiami del passato, crocevia del futuro, ferite di generazioni, condizione giovanile e mass-media, responsabilità della scienza e problemi della fede. Ma anche il travaglio della sofferenza fisica, la debolezza dell’assistenza ospedaliera, che spesso non supera l’atto tecnico, gli interrogativi dell’etica medica le manipolazioni genetiche.
La natura essenziale dell’uomo è definita da qualità che non si trovano in altre forme di vita. Secondo lei la scienza, con le sue sperimentazioni spinte, sta minando l’entità vera dell’essere?
Mi chiedo dove siano queste qualità dell’uomo che lo fanno unico nella sua diversità. Secondo i biologi sono nella capacità di riprogettarsi, di darsi perfino un’altra natura. In questa prospettiva le promesse, o le minacce, sono esplicite. Avremo dunque esseri paraumani nel senso che la loro programmazione avverrà all’interno del seme da cui nasceranno? Sarà il DNA che attraverso l’uomo vedrà se stesso o sarà l’uomo a specchiarsi nel suo DNA? L’essenza dell’uomo è nel valore di ciò che egli compie e la scienza sta mettendo le mani da tempo su questo valore. Ma dal giorno in cui Socrate isolò la natura dell’uomo come un problema a sé, la biologia non è ancora riuscita a dirci con certezza se siamo un progetto originario dell’esistenza o un fatto fortuito.
Che cosa succederebbe se si sovvertisse il naturale misterioso incontro dei cromosomi? Se si riuscisse a “costruire” con geni scelti un essere pressoché vicino alla perfezione?
Nessuno, credo, sarà disposto a far bollire tanto l’alambicco. Comunque ci aveva già pensato Hitler e per fortuna non c’è riuscito. Ma anche Robert Graham, il miliardario americano che voleva “rifare il mondo suscitando una nuova intelligenza dell’uomo”. L’idea era suggestiva. Far inseminare artificialmente donne intelligentissime con il contributo di uomini il cui talento avesse ricevuto la certificazione del premio Nobel. Graham si dichiarava pronto a sponsorizzare i virgulti di una nuova razza finalmente in grado di cambiare il mondo. Resta da vedere che fine avrebbero fatto questi figli con i cromosomi calcolati. Forse venduti allo Stato o a una fondazione genetica?
Crede che manomettere le “faccende” della natura comprometterebbe anche i rapporti più stretti, quelli della famiglia?
L’essere dello stesso sangue finirà quando si attingerà ad un unico rubinetto, quello del fluorocarbonio. Un sessantasettenne testimone di Geova del Minnesota anni fa fu il primo uomo a ricevere, in luogo del plasma, il fluorocarbonio. La trasfusione mise a rumore mezzo mondo sollevando problemi che coinvolgevano la genetica, l’etica e la psicologia. Da quel momento il primo mito dell’identità, il sangue, è ormai una questione tecnologica. Senza contare la stravolgente notizia giunta della scienza che il sangue è l’ultimo dei veicoli genetici.

SERGIO ZAVOLI E FEDERICO FELLINI
Nessun intimo convincimento prevarica la scienza a vantaggio della vera appartenenza generazionale?
Un giorno mio fratello mi si rivoltò contro, una futilità di quelle che spesso dividono i bambini. Nostra madre cercò di rimettere pace dicendogli con gravità: “Non dimenticare che tuo fratello ti ha dato il sangue!” In realtà non mi ero immolato: una piccola trasfusione per mettere i germi del mio morbillo nel suo sangue, stimolare gli anticorpi e scongiurare il contagio. A tutta la famiglia l’impresa era costata una bistecca, un paio di uova e un bicchierino di Marsala. Non c’erano motivi, dunque, per incitare alla riconoscenza. Eppure quelle parole mi lasciarono un segno e dovettero lasciarlo anche mio fratello se il travaso tornò più volte nei nostri discorsi.
Aldilà dei velleitari propositi di ingarbugliare le regole, l’utilizzo della scienza al fine della vita stessa ha dato risultati sorprendenti. I trapianti per esempio…
Certamente. Il primo esperimento che Christian Barnard operò nel 1967 con il trapianto cardiaco segnò una svolta significativa nella storia della medicina. La manipolazione giunta al più “intoccabile” degli organi, fu una data di sconsacrazione o l’inizio di un’altra sacralità? Se è vero che persino il cuore, da adesso, in qualche modo si comanda, è lecito mettere in conto il superamento di ogni altra barriera? È curioso: l’illusorio centro dei sentimenti, il cuore degli stilnovisti d’ogni tempo, può risultare trapiantabile e rimane nonostante tutto quel centro pulsante che tiene in movimento il traffico vitale.
Non solo moti dell’anima…
Il trapianto coinvolge tormenti morali difficili da sedare. Ma la scienza sembra non farsene carico. Quando, a suo tempo, ho chiesto Barnard come mai non avesse risposto esaurientemente all’obiezione secondo la quale lui toglieva il cuore a un individuo clinicamente morto, ma che aveva ancora in sé lieviti di vita, mi ha risposto che se volessimo essere onesti dovremmo ammettere che noi continuamente seppelliamo gente ancora viva. Sosteneva cioè che quando una persona viene sepolta il giorno dopo la sua morte, ci sono parti del corpo clinicamente ancora in vita. Quindi la sua coscienza scientifica e anche quella umana erano a posto.

Che cosa rimane da fare secondo lei a chi è afflitto da un male cosiddetto incurabile?
La malattia non è un nascondiglio. Purtroppo la persistente debolezza delle istituzioni sanitarie trasmette ondate di sfiducia che spingono la speranza in direzione dei miracoli variamente promessi da uno stuolo sempre più folto di “guaritori”. L’abbandono alle pratiche miracolistiche non è una scelta, ma l’estremo rifugio offerto dalla sconsolatezza. Avallarlo con il pretesto della misteriosità del male, e quindi con l’alibi di non poter negare nessuna ipotesi di guarigione, è una colpa più spesso dovuta all’ignavia che all’ignoranza. Tra noi e la malattia va dunque abbattuta ogni intercapedine romanzesca. Se la malattia è un tunnel, è un reato di omissione scientifica e umana, è una colpa civile e sociale lasciare che chi lo attraversa in barella non possa credere e persino pretendere di uscirne.
Bisognerebbe vedere la morte come la più remota conclusione del male? Qualcosa di orrido da cui tenersi alla larga il più possibile?
Nei seminari sulla morte che non di rado rimangono un grande pettegolezzo su un mistero, nessuno dice che molte cose sono consigliabili in questo o quel caso, ma che per tutti il peggiore dei mali non è forse morire ma morire soli. In passato in un ospedale americano è stato calcolato, cronometro in mano, il tempo che i medici dedicano ai malati: meno di tutti va ai moribondi. Intorno ad essi l’organizzazione sorvola o si muove svelta. Un’occhiata, un daffare breve e automatico, l’orecchio ad altre chiamate, alla vita che resiste in altri letti. Dove ormai si muore, c’è solo un corpo svuotato via via di coscienza: è l’alibi dell’abbandono. Un abbandono che spesso comincia molto prima, dal giorno in cui, privato del dialogo, il malato ha perduto, con gli altri, se stesso.
Come ci è dato gestire la nostra stessa salute?
È un grosso problema l’uso della salute. Non è un processo alla scienza ma alla politica che se ne può fare. Tant’è che ha la fama di essere “buona” quella per esempio che investe sulla salute, che sarebbe dalla parte della vita e “cattiva” quella che, investendo sui consumi, sarebbe dalla parte, poniamo, degli inquinatori. Una scienza che, dato il suo uso, consideriamo la più umanitaria di tutte, è quella da cui discende la produzione farmaceutica. Non c’è uomo, per sano che sia, nel cui futuro possa escludersi l’ipotesi di una malattia e, per ciò stesso, di qualcosa che lo aiuti a guarire. Quando poi quest’ultimo si ammala, stabilisce quasi sempre un rapporto acritico con la malattia e mitico con il medicinale. In mezzo tra malato e medicinale, il medico. Sta a quest’ultimo non sorvolare sul rapporto umano ed evitare che l’uso inderogabile del farmaco diventi l’unica soluzione.
Quanto alla salute psichica?
Con questa scienza che ogni giorno ci propina un dubbio sulla nostra salute psichica, bisognerebbe cominciare a discutere. Io ho un vitalismo di natura molto semplice, sono grato alla vita del puro fatto di esistere e se c’è qualcosa di attonito nel mio essere vivo, è l’idea che avrei potuto non nascere. Ma la scienza mi avverte che sono nato male, che porto in me i segni di una nascita che, in nessun caso, poteva dispormi all’ottimismo. Se il passaggio dallo stato fetale a quello, per così dire, sociale si realizzasse senza una serie di traumi esterni (la stanza illuminata, i suoni, i rumori, la manipolazione del corpo, il bagno), il distacco avrebbe limiti sopportabili. La perdita della condizione prenatale ci priva dolorosamente di “quell’altro” che pur eravamo e inaugura un essere che, a giudicare dalla felicità precedente, non avevamo nessuna voglia di diventare.
Quale sarebbe allora la condizione ottimale per venire al mondo?
Non più lampade accese, né voci alterate, né rumori aggressivi, né giravolte, né lavacri. Bisogna nascere in penombra e nel silenzio e poi restare adagiati, zuppi d’acqua materna per ore e ore, finché non sia compiuto il creaturale stupore d’essere nati. Forse. Ma io sono nato dalle mani di una levatrice che ha bollito il suo armamentario dentro la pentola dei cappelletti. Mio padre sturò volentieri 23 bottiglie di Sangiovese mettendo a rumore mezzo quartiere. Mi riempirono di schiaffoni perché non mi decidevo a frignare; fui tolto a mia madre per diversi giorni finché non le passò la mastite. E sono qui con la psiche ancora posto e una dose di ottimismo che non credo becero.
Nonostante tutto lei ha molto rispetto per la scienza della medicina. Crede nella professione del medico come missione?
Un personaggio emblematico in questo senso è sicuramente Albert Schweitzer, che ho incontrato a Lambarené, dove operava la sua missione. Il protestante più critico del protestantesimo liberale, uno tra i cristiani più aristocratici e francescani, un filosofo pervaso di umanesimo e tuttavia in ritardo sul cammino dell’uomo. La sua è stata una storia di prodigiosi dilemmi e di drammatiche contraddizioni.
Schweitzer non aveva dedicato solo la sua vita e la sua professione, ma anche il suo essere più intimo a quell’Africa…
Quando gli chiesi perché avesse rifiutato un ospedale più moderno, mi rispose che nessuno glielo aveva offerto quindi non aveva potuto rifiutarlo. Disse che in ogni caso non sarebbe stato possibile costruire un ospedale moderno e al tempo stesso adatto a quei luoghi; che lì non serviva neanche il telefono per avvertire qualcuno della morte di un suo congiunto perché chi si recava da lui portava con sé familiari e cose per morire, se doveva morire, come se fosse stato a casa sua.
C’è dunque un limite che accomuna la medicina tecnologica e quella primitiva della missione…
Fermarsi di fronte all’ineluttabile