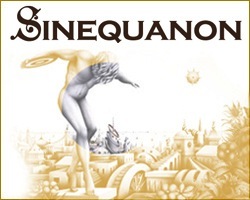Testo e foto di Teresa Carrubba
Mal d’Africa. Per molti è l’atmosfera selvaggia dei parchi naturali, i branchi di elefanti, la fierezza dei leoni, di una terra sconfinata e senza tempo, delle tribù guerriere dai volti tinti di simboli, delle danze ossessive al suono ossessivo di tamburi, del mare caldo in cui vagano sinuosi sciami di pesci che sembrano dipinti a mano. A me è rimasto negli occhi e nel cuore quello sguardo…. Uno sguardo smarrito, dalla tristezza congenita che non conosce né spera alternative. Lo sguardo delle frotte di bambini malvestiti e scalzi che, come per una sorta di tacito tam-tam, si precipitavano giù dalla montagna, sbucati non si sa da dove, ogni qualvolta la nostra carovana di fuoristrada faceva una sosta per permetterci di fotografare e sgranchirci le gambe.
Scendevano giù, soli o con adulti, non una parola, ma con quello sguardo più eloquente di qualsiasi discorso. Ci circondavano stretti, occhi verso l’alto, mostrando timidamente l’accenno di una mano. Per ricevere. Non soldi, no, che se ne farebbero in quel territorio aspro e desolato dell’acrocoro etiope, dove anche per istruirsi devono percorrere vari chilometri a piedi sotto un sole gagliardo prima di raggiungere la scuola? Quella mano incerta chiede una penna, un quaderno, dolciumi, una maglietta. Qualcosa in cui, seppur piccola, non sono avvezzi a sperare. E quello sguardo carico di rassegnazione, per un attimo veniva trafitto da un lampo di luce, un misto di gratitudine e di dolcezza, quando noi attingevamo nei sacchi di acquisti mirati regalando loro scarpe, magliette e biscotti. Indossandoli subito, si sentivano trasformati, ma prendevano volentieri il sacchetto con il vecchio lacero vestito da portar via. Dignità, saggezza? Forse tutte e due, forse l’indigenza è un’insegnante migliore del benessere. Mal d’Africa. Nostalgia di un mondo dimenticato, dove la scala delle priorità ha ben pochi gradini. Dove ci s’incanta, con gli occhi pieni di stupore, ammirazione e tristezza, di fronte alla commovente processione di persone che si spostano da un mercato all’altro scendendo dalla montagna in un percorso accidentato, con pecore, asini, povere mercanzie e granaglie spesso trasportate da donne, in ceste sulla testa.

Se non fosse uno scenario che stringe il cuore, ci sarebbe da ammirare la fierezza di uomini anziani che affrontano una fatica sedimentata negli anni ,tenendo a bada la loro capretta che con ogni probabilità cercheranno di vendere per sopravvivere. E la notoria bellezza delle donne etiopi dai coloratissimi abiti che portano con sé scialli di cotone lavorati al telaio o tonde ceste di paglia intrecciata in cui trasportano giganti sfoglie sovrapposte di ingera, pane etiopico ottenuto dalla fermentazione di un cereale locale, il teff. Una sorta di piadina dal gusto acidulo. Abbiamo incrociato una di queste processioni nei pressi di Bahar Dar, lungo la salita impervia necessaria per raggiungere Tississat, la spettacolare Cascata del Nilo Azzurro. Durante la salita, per noi più aspra che per gli avvezzi etiopi, il sole è impietoso, le leggere folate di vento alzano la sottile polvere e mescolano gli odori pungenti della frutta e delle erbe trasportate. E di ben altra merce, che qui in Etiopia si è diffusa rapidamente, il qat, una speciale erba venduta in mazzetti più o meno grandi. Masticate a lungo, le foglioline fanno sparire la fame e la fatica e regalano un senso d’euforia, una via di fuga dai tanti problemi.

In cima alla salita, annunciata dal fragore dell’acqua nel totale silenzio, la magnifica Cascata del Nilo che precipita per 50 metri in una gola suggestiva alla fine di una parete di basalto, tufo e ossidiana. Il sole violento rifrange luce sull’acqua nebulizzata creando spettacolari arcobaleni nell’aria tersa d’alta quota. L’effetto sorpresa è garantito in quest’oasi idilliaca che, ci hanno assicurato, a settembre si ricopre di coloratissimi fiori. Tutt’altro contesto a Gondar, considerata una delle città più interessanti dell’Etiopia, dal passato glorioso, che mantiene la maestosità del periodo degli imperatori (‘600 e ‘700) attraverso i castelli, come quello spettacolare di Fasiladàs con le sue imponenti torri, e quello di Iasù I, a pianta rettangolare. E alcune superstiti delle sue 44 chiese antiche, tra cui, davvero singolare, quella di Debre Berhàn Selassiè con un superbo soffitto interamente dipinto a teste di “serafini”.

Ma la chicca dell’acrocoro dell’Etiopia, e forse di tutto il Paese, è Lalibela, a un’altitudine tra i 2500 e i 3000 m. dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Ci si arriva attraverso una lunga strada costruita dai cinesi che costeggia villaggi e vallate e poi per strade sterrate di montagna che seguono il percorso del fiume Takazzè. E’ qui che deve venire il viaggiatore che intende scoprire l’Etiopia più genuina, quella che affascina. I mille villaggi con le case costruite con tralicci di legno, fango e paglia, talvolta in pietra nelle zone montane, sono la vera immagine di quest’area la cui vita quotidiana gravita intorno al mercato, alla chiesa e al bunna-bet, il caffè, punto d’incontro locale. La strada è uno spaccato della vivacità di questi centri abitati. Un continuo viavai di persone, di carretti, di animali. Bambini e ragazzi che vanno a scuola con le loro divise colorate, uomini che trascinano fagotti o camminano appoggiando i polsi su un leggero bastone posto sulle spalle, giovani donne vestite all’europea e ben curate. Lungo la strada capita di incrociare un nutrito gruppo di persone meste con vesti bianche, che seguono un funerale o, in aperta campagna, all’ombra di un’immensa acacia, un assembramento di uomini tutti in piedi attorno all’albero intenti a discutere di qualcosa d’interesse comune per il villaggio.

Da lontano non si vede, Lalibela. Il luogo santo della città si apre quasi all’improvviso nella roccia su cui si cammina. Per primi si scorgono i tetti separati da profondi cunicoli che girano tutt’intorno ai templi, trasformandosi in cortili, passaggi, portici. Dopo la presa di Gerusalemme da parte del Saladino, per favorire i pellegrinaggi ormai impraticabili in Terra Santa, il re Lalibela decise di fondare qui una seconda Gerusalemme, a Roha, che divenne centro di attrazione per tutta l’Etiopia. Chiamò centinaia di architetti, scalpellini e manovali. Svuotarono giganteschi monoliti creando all’interno la struttura di una chiesa. Undici copie di altrettanti luoghi santi, che costituiscono il più interessante complesso di chiese rupestri del mondo. Chilometri di cunicoli collegano le sue diverse unità attraverso cripte e spelonche nella cui apertura c’è sempre un monaco rannicchiato sul suo libro di preghiera. Sorgenti sotterranee alimentano grandi vasche limacciose per le immersioni rituali. Attraverso lunghe scale di gradini stretti, gremite di fedeli, inizia una discesa nella Lalibela sotterranea dove la fede è fatta di gesti elementari, che uniscono i misteri del Cristianesimo con l’anima africana.

C’è chi all’ingresso di ogni chiesa si prostra a terra e bacia la pietra che per questo diventa scivolosa. Poi rende omaggio alla croce che il monaco ogni volta tiene in mano per mostrarla ai fedeli. Una diversa dall’altra, le croci copte sono un prezioso amalgama di misticismo e arte orafa per via della perfetta realizzazione che le rende anche appetibili come acquisto per la memoria del viaggio. Le chiese sono ancora suddivise in tre settori, quello centrale è il sancta sanctorum, dove possono entrare solo i sacerdoti e che è chiusa alla vista del pubblico. Il secondo è riservato alla celebrazione della messa cui prendono parte i diaconi, mentre il terzo è aperto ai fedeli che intendono comunicarsi, cioè che sono puri. La maggior parte della gente resta fuori, nel cortile o nel giardino della chiesa, che è sempre la parte più affollata in quanto la tradizione copta è molto esigente sullo stato di purezza necessario per entrare in chiesa.